

Questo sito utilizza i cookies per il funzionamento. Cliccando su Ok ne consenti l'utilizzo


![]()

Una rete di percorsi verdi per ciclisti e pedoni, alternativi ai congestionati flussi automobilistici, che possano riconnettere tutte le aree latenti recuperabili: tra loro, alla città e al territorio. E' questa la trama di base su cui s'innestano gli altri temi dell'indagine: recuperare le frange vuote, irrisolte, sottoutilizzate non basta infatti per ottenere una miglior qualità della vita cittadina. Così, queste ipotetiche piste "pulite" potrebbero collegare in modo inedito le due sponde del centro e della prima periferia, separate dalla circonvallazione novecentesca: una passerella al di sopra dei parterre di auto in corsa cucirebbe il centro alla fascia tra i viali Mentana e Fratti, con l’ex Consorzio Agrario, i parcheggi, i centri direzionali e commerciali, fino all’ex Macello, e più oltre all’area del Gasometro, fino ai tracciati ciclo-pedonali provenienti dal parco fluviale del torrente lungo la massicciata ferroviaria. Questi ultimi permetterebbero di connettere tanti margini sprecati generati dal taglio netto dei binari. Una frattura nel tessuto urbano, quella ferroviaria, che può mutarsi, con onere relativamente modesto, in una grande “sutura unificante” grazie a corsie differenziate per cicli e pedoni, distese lungo il grande arco di cerchio disegnato dentro la città dalle rotaie della Milano-Bologna e della Parma-La Spezia. E quale miglior asse portante di quello fluviale, per consolidare la struttura dei percorsi tra tanti episodi di verde, siano giardini antichi o meno, oppure oasi protette? Nel rispetto delle oasi naturalistiche, le golene del Parma e del Baganza permetterebbero suggestive escursioni tra grandi residenze signorili del passato, dal castello di Torrechiara alla rocca di Sala Baganza, fino alla Versailles dei duchi di Parma, la reggia di Colorno. Quasi un “asse della cultura” che riunifica lungo argini e golene i tesori d’arte delle antiche tenute ducali, passando per il campus universitario, il centro della città antica e il CSAC all’abbazia di Paradigna. Dalla stazione ferroviaria, tra l'altro, gli studenti che arrivano a Parma in treno, potrebbero utilizzare questo percorso per raggiungere il campus, la sede centrale dell’ateneo e le facoltà è presso il parco ducale, o gli istituti superiori di viale Maria Luigia.
La ricerca di una viabilità alternativa a quella motorizzata è da tempo una necessità prioritaria nelle città italiane, non soltanto negli agglomerati metropolitani, ma anche nelle urbes di provincia, specialmente là dove il suolo pianeggiante consente un ampio uso della bicicletta.
La soluzione non è comunque semplice ed immediata e richiede approfonditi studi delle latenze che ogni singola città possiede, in virtù della configurazione storica e delle nuove esigenze di sviluppo (non solo e non più quantitativo ma piuttosto qualitativo).
Bisogna inoltre prendere atto che, al di là delle teorizzazioni astratte, l'obiettivo oggi è quello di una "utopia possibile" del restauro urbano, che individua nei percorsi viabilistici e nel ripensamento del sistema dei trasporti il ganglio vitale per una nuova qualità dell'abitare. Un approccio pragmatico ("transattivo" per dirla con Freedman) che alle certezze di una disciplina urbanistica geometrico-euclidea sostituisce la relatività dei concetti spazio-temporali dell'osservatore-utente, cercando di superare al meglio le contraddizioni insite nell'esistente - spesso di difficile individuazione ed eliminazione, soprattutto nei tempi brevi - con piani in cui alla visione globale dei problemi si accompagna un'attenzione particolare per la soluzione di dettaglio.
La strategia dei percorsi ciclo-pedonali che si propone per Parma cerca di ovviare ai problemi più urgenti di traffico veicolare e inquinamento senza mettere in discussione tutti i problemi del territorio urbano e la sua gestione prospettando avveniristiche realtà ideali (con la conseguente elaborazione di mastodontici ed onnicomprensivi piani, dalla dubbia efficacia ma dalla sicura lunghissima, dispendiosa e per questo spesso impossibile realizzazione). Tale strategia cerca piuttosto di offrire subito delle soluzioni che sfruttino l'esistente con attuazioni immediate e verifiche a tempi brevi, anche perché interessano prevalentemente aree pubbliche e non richiedono faticosi ed impopolari espropri.
Insomma, questa proposta di viabilità ciclo-pedonale per Parma vorrebbe essere un esempio paradigmatico di come si possa, nell'immediato, intervenire sul tessuto urbano senza stravolgerlo ma, ascoltandone il linguaggio interstiziale, fornire soluzioni che servano di avvio ad un'operazione su più vasta scala, da attivarsi parallelamente o in tempi successivi.
La proposta è una sorta di "ideogramma" (fig. 2.2) per un sistema di viabilità verde che si inserisca nella città mutuando e ribaltando in modo provocatorio - per non dire rivoluzionario – gli schemi consueti dalla viabilità motorizzata (circonvallazioni e assi di scorrimento). Non quindi insignificante che si proponga oggi un "percorso verde" (con tutte le necessarie cautele per l'ecosistema fluviale, che va assolutamente tutelato, come illustrato al cap. 1) proprio lungo quelle golene dove invece il Piano Regolatore del 1969 prevedeva una specie di "autostrada urbana".
Analogamente si può dire per la circonvallazione destinata agli autoveicoli, che ha inanellato negli ultimi decenni non solo Parma ma quasi tutti i centri urbani. Ripetutamente proposta nei Piani come un refrain di sicuro successo e - spostandosi via via verso l'esterno – classificata come "tangenziale", viene invece reinterpretata in questo progetto in termini di viabilità verde e ciclo-pedonale, e ribaltata così nel suo significato originario. Un tale anello è immaginato nell'arco settentrionale lungo la massicciata della ferrovia e in quello meridionale come "ricucitura" delle aree di frangia - già organizzate a verde o semplicemente individuate nella loro latenza - attualmente frammenti polverizzati, spesso sottoutilizzati o abbandonati, che solo un'opportuna riorganizzazione può far rientrare di diritto tra le risorse urbane.
Questi percorsi ciclo-pedonali, con gli attraversamenti progettati (per lo più semafori a raso e a richiesta), potrebbero inoltre offrire un antidoto soft, ma di grande importanza sociale, per limitare la ghettizzazione di alcuni quartieri periferici, isolati dalle arterie a traffico automobilistico che sono, a tutti gli effetti, vere e proprie "barriere" fisiche, oltre che psicologiche, all'integrazione delle singole porzioni di città.
Il risultato finale di questa operazione non sarebbe la semplice somma degli addendi, ma un nuovo sistema a valore aggiunto, in cui le peculiarità di ogni zona siano valorizzate e integrate proprio in virtù di quel recupero dei percorsi - non semplici "nulla" tra una destinazione e un'altra ma momenti ricchi di percezioni spazio-temporali.
I nuovi percorsi realizzerebbero il necessario coordinamento degli interventi di riqualificazione delle aree marginali, e trarrebbero forza nella continuità dei tracciati, premessa davvero indispensabile per la buona riuscita dell'operazione, come gli interventi tentati in passato, falliti perché frammentari, stanno a testimoniare con evidenza. Per citare un esempio locale, anche la bella pista di Via Varese, soluzione ideale di ciò che si auspicherebbe per gli altri tracciati, senza un collegamento col resto della maglia non è purtroppo che un isolato segmento poco sfruttato (2.3, 2.4).
Naturalmente con quanto detto non si vuole ridurre ai soli tracciati "forti" di questa nostra proposta - che intenzionalmente riveste un carattere emblematico - l'intero sistema delle piste ciclo-pedonali realizzabili in città. Tale sistema complessivo dovrà invece confrontarsi con situazioni disagiate da risolvere capillarmente: è ciò che il Comune si propone di realizzare col piano di viabilità ciclo-pedonale approvato negli anni passati e che si spera di prossima attuazione.
Ma i principi che hanno guidato questo progetto emergeranno meglio se si comincerà ad analizzare il tracciato previsto: ognuno di noi può, chiudendo gli occhi, immaginare di percorrerlo sia in bici che a piedi, desideroso di passeggiate non turbate dal rumore o dai gas di scarico delle automobili.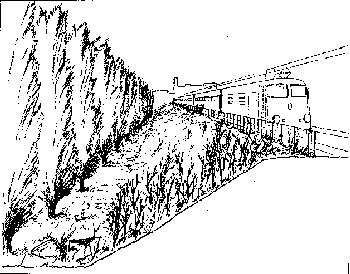 Cominciamo dalla massicciata della ferrovia:
Cominciamo dalla massicciata della ferrovia: 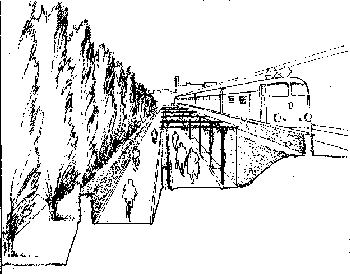 per trasformarla in "sutura unificante" (K. Linch) anziché barriera di isolamento si è progettato di affiancare ai binari un doppio nastro continuo di viabilità differenziata (per pedoni e per cicli), a livelli diversi, allo scopo di sfruttare l'attuale pendio della scarpata. Un pergolato a tunnel protetto da rampicanti potrebbe allietare la passeggiata dei pedoni e opportunamente schermare gli spostamenti d'aria ed i rumori dei treni, nonché il pericoloso lancio di oggetti dai finestrini (figg. 2.6, 2.7).
per trasformarla in "sutura unificante" (K. Linch) anziché barriera di isolamento si è progettato di affiancare ai binari un doppio nastro continuo di viabilità differenziata (per pedoni e per cicli), a livelli diversi, allo scopo di sfruttare l'attuale pendio della scarpata. Un pergolato a tunnel protetto da rampicanti potrebbe allietare la passeggiata dei pedoni e opportunamente schermare gli spostamenti d'aria ed i rumori dei treni, nonché il pericoloso lancio di oggetti dai finestrini (figg. 2.6, 2.7).
In corrispondenza dei sovrappassi sulle principali strade e sul ponte, si potrebbero realizzare passerelle pensili, agganciate alla massicciata (2.9, 2.10).
Il principio di utilizzare il declivio della massicciata ferroviaria come sede per i nuovi nastri ciclabili e pedonali, già proposta da noi per Parma durante il Convegno del 1989, pare ancora accattivante, anche per la possibilità di estensione del principio in tutte le città di pianura di dimensioni analoghe. Anche sotto il profilo normativo e patrimoniale tale principio non sembra trovare contraddizioni od ostacoli.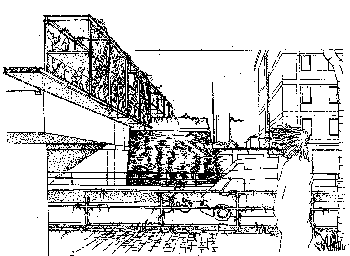 Piace poi constatare che, seppur in diverse caratteristiche ambientali, anche in città all'avanguardia nella realizzazione di viabilità ciclabile, come Munster, le soluzioni adottate sono in qualche modo comparabili - se non assimilabili - a quelle del nostro progetto: anche a Munster lo schema dei nuovi percorsi ciclabili segue la configurazione centrica del tessuto storico, proprio come si propone per Parma, e la connessione treno-bici è assai praticata, specie per chi si reca al lavoro (vedi pag. ). Proprio nelle città del nord Europa (Olanda, Germania, Danimarca), la tradizione della bicicletta è più radicata che in Italia, benché Parma e le altre città emiliane possano vantare un buon primato nell'utilizzo delle due ruote. In molti centri urbani perciò la rete ciclo-pedonale ha raggiunto livelli di sperimentazione avanzati, proponendo un'efficace integrazione tra una rete "forte" di percorsi separati (quasi una città nella città, alternativa a quella percorribile con gli autoveicoli) e vie a traffico promiscuo, caratterizzate da facili e immediati interventi sovrastrutturali (segnaletica, incroci con aree di attesa per i ciclisti, pavimentazioni cromatiche delle sedi stradali). Tali realizzazioni sono indispensabili soprattutto nel centro cittadino, dove la ristrettezza delle carreggiate spesso impedisce un'efficace separazione dei flussi.
Piace poi constatare che, seppur in diverse caratteristiche ambientali, anche in città all'avanguardia nella realizzazione di viabilità ciclabile, come Munster, le soluzioni adottate sono in qualche modo comparabili - se non assimilabili - a quelle del nostro progetto: anche a Munster lo schema dei nuovi percorsi ciclabili segue la configurazione centrica del tessuto storico, proprio come si propone per Parma, e la connessione treno-bici è assai praticata, specie per chi si reca al lavoro (vedi pag. ). Proprio nelle città del nord Europa (Olanda, Germania, Danimarca), la tradizione della bicicletta è più radicata che in Italia, benché Parma e le altre città emiliane possano vantare un buon primato nell'utilizzo delle due ruote. In molti centri urbani perciò la rete ciclo-pedonale ha raggiunto livelli di sperimentazione avanzati, proponendo un'efficace integrazione tra una rete "forte" di percorsi separati (quasi una città nella città, alternativa a quella percorribile con gli autoveicoli) e vie a traffico promiscuo, caratterizzate da facili e immediati interventi sovrastrutturali (segnaletica, incroci con aree di attesa per i ciclisti, pavimentazioni cromatiche delle sedi stradali). Tali realizzazioni sono indispensabili soprattutto nel centro cittadino, dove la ristrettezza delle carreggiate spesso impedisce un'efficace separazione dei flussi.
Nella nostra città, oltre al segno forte della linea ferroviaria a nord-ovest del perimetro urbano, utile guida per il nuovo anello di viabilità alternativo, è necessario individuare anche per la parte meridionale ed orientale della città un filo che, seppur tenue, funga da conduttore. La diramazione del binario morto che un tempo serviva per il trasporto delle barbabietole dallo zuccherificio Eridania allo scalo merci ci indica ad esempio una direzione da seguire.
Dal parco dell'ex opificio, per il quale si prevede un recupero anche delle monumentali strutture produttive (vedi cap. 10), proseguendo oltre la via Emilia Est, si possono sfruttare le stradine residenziali del quartiere adiacente, che forse da trasformarsi a senso unico, recuperando parte della carreggiata per il transito delle biciclette e magari piantando alberi lungo la linea di separazione. Giunti allo stadio Tardini, attraversando poi il parco adiacente e Via Torelli, si raggiungono i viali ombreggiati dai tigli intorno alla Cittadella. Qui, lungo le strade esistenti e in parte le recuperande bassure, è possibile riproporre la "promenade entre la ville et la Cittadelle" ricordata dal Lalande (vedi Cap. 5), recuperando con la memoria - seppure solo parzialmente - un po' di quella suggestione che doveva caratterizzare la passeggiata sottomura (o sui bastioni) nell'Ottocento, prima della demolizione del sistema difensivo sul finire del secolo.
Immediatamente oltre Viale Solferino la pista prosegue fino ai Lungoparma attraversando un altro brandello di città che necessita di riqualificazione: sarebbe infatti possibile trasformare Piazza Volta - perno di un complesso religioso-cultural-ricreativo - in un luogo piacevole a traffico pedonale, magari realizzando quel parcheggio sotterraneo, con posti auto in parte privati e in parte pubblici, segnalato dalle tavole del Piano Regolatore. Via Pozzuolo del Friuli e Via Rondizzoni diventerebbero così sensi unici e potrebbero essere attrezzate con una pista ciclabile alberata.
Il monumentale nucleo scuola-cinema-piscina, realizzato durante il Ventennio, seppure di architettura un po' retorica, potrebbe essere recuperato con un attento restauro, mentre la costruzione di un edificio-portale davanti alla chiesa offrirebbe finalmente una facciata ed un approccio più consoni al luogo sacro, oltre a dare l'occasione per la realizzazione di un possibile volume affacciato sulla piazza pedonalizzata (figg. 2.11-2.17): un bar può essere utile, oltre ad attrezzature commerciali e naturalmente a servizi collettivi.
La nuova struttura fungerebbe contemporaneamente da quinta per la piazza (schermabile nei due lati minori da filari alberati), nell'intento di realizzare quel sagrato - non solo nartece e luogo di ritrovo per la comunità ecclesiale ma anche momento di "pausa urbana" - di cui oggi si avverte drammaticamente la mancanza (2.12-2.17).
Proseguendo verso il torrente, il percorso ciclo-pedonale che si propone valicherebbe i bracci del Parma e del Baganza, attestandosi sulla penisola di confluenza, attorno a cui si è miracolosamente conservata una porzione boschiva di vegetazione ripariale; l'attraversamento è progettato prevedendo due passerelle non allineate: un tramite urbano molto importante perchè servirebbe a relazionare con il resto della città il quartiere Montanara, oggi collegato soltanto dal Ponte Dattaro, intensamente trafficato. La salvaguardia dell'oasi agro-faunistica conservatasi lungo le sponde non verrebbe minacciata dalle nuove strutture, progettate con discrezione e sensibilità per integrarsi nel paesaggio, fasciate di rampicanti alla stregua di un lungo pergolato sospeso, e realizzate con leggere strutture reticolari che ricordano tra l'altro - seppure a scala diversa - l'antico progetto per il Ponte Bottego presentato dalla Società Italiana Costruzioni Metalliche alla fine dell'Ottocento.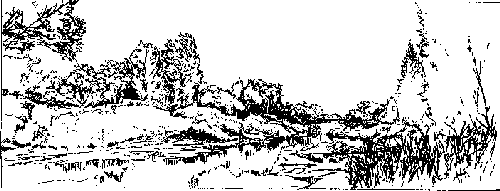 Il recupero dell'elemento naturale all'interno di una logica di restauro urbano costituisce forse la più importante occasione per soddisfare a un'esigenza ripetutamente espressa dagli abitanti delle città contemporanee.
Il recupero dell'elemento naturale all'interno di una logica di restauro urbano costituisce forse la più importante occasione per soddisfare a un'esigenza ripetutamente espressa dagli abitanti delle città contemporanee.
Proprio sulla punta della penisola, il luogo suggerirebbe un calibrato intervento architettonico, un piccolissimo belvedere nel punto di snodo del percorso, consentendo così di ammirare quel che ancora resta di quel paesaggio fluviale già raffigurato dal Ravenet nelle sue "vedute" (figg. 2.22 -2.33).
Il sobrio consolidamento delle sponde, finalizzato ad assecondare il percorso in prossimità del Baganza, coniugato con i minimali interventi che definiscono i momenti salienti del sistema di attraversamento dell'area, sarebbe anche occasione per migliorare i dintorni del centro sportivo universitario, attualmente piuttosto casuali, recuperando e valorizzando vaste porzioni di aree pubbliche.
L'approdo della passerella sul Baganza consentirebbe di riconnettere all'intero sistema la pista ciclabile esistente in Via Varese, attribuendo anche un nuovo significato al luogo di ristoro collocato in una posizione davvero strategica, ideale anche per collocarvi, magari, un posteggio e un noleggio di biciclette.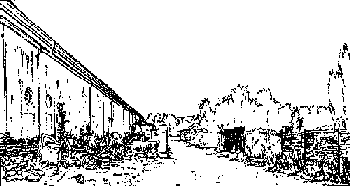 Proseguendo la nostra immaginaria passeggiata verso ovest, scorgiamo la massa imponente del cimitero della Villetta, raffigurato dai Camignani nelle loro vedute, un tempo monumentale emergenza isolata in mezzo alla pianura coltivata protetta da un alto muro e oggi invece forzatamente segregata e assediata dalle lottizzazioni post belliche. La
Proseguendo la nostra immaginaria passeggiata verso ovest, scorgiamo la massa imponente del cimitero della Villetta, raffigurato dai Camignani nelle loro vedute, un tempo monumentale emergenza isolata in mezzo alla pianura coltivata protetta da un alto muro e oggi invece forzatamente segregata e assediata dalle lottizzazioni post belliche. La 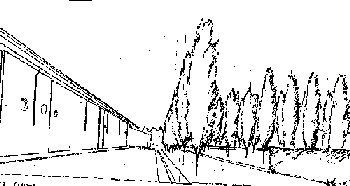 pista ciclo-pedonale, costeggiando la cortina muraria a nord (oggi purtroppo deposito di materiali in disuso, se non discarica), attraverserebbe un'area di risulta che potrebbe essere ripensata a parco, in prossimità degli orti comunali. Due filari alberati servirebbero a segnalare il nuovo percorso, riqualificando la zona di rispetto del cimitero (figg. 2.34 - 2.39), oggi parzialmente erosa dalle recenti costruzioni dei magazzini riuniti, di cui è già però previsto il trasferimento.
pista ciclo-pedonale, costeggiando la cortina muraria a nord (oggi purtroppo deposito di materiali in disuso, se non discarica), attraverserebbe un'area di risulta che potrebbe essere ripensata a parco, in prossimità degli orti comunali. Due filari alberati servirebbero a segnalare il nuovo percorso, riqualificando la zona di rispetto del cimitero (figg. 2.34 - 2.39), oggi parzialmente erosa dalle recenti costruzioni dei magazzini riuniti, di cui è già però previsto il trasferimento.
Il percorso ciclo-pedonale dal cimitero a via La Spezia tocca, anzi attraversa questi edifici.
Comunque, supponendo di recuperare tutti i capannoni, nell'insieme di assai scarsa qualità architettonica, se pure di buona consistenza strutturale., non solo funzionalmente ma anche come immagine, e nella ricerca di individuare un nuovo luogo a frequentazione urbana, si possono suggerire per essi diverse destinazioni: commerciali ad esempio. Unica importante testimonianza di archeologia industriale è quello con capriate Polonceau appoggiate su colonnine di ghisa, probabilmente in origine situato altrove): mercato rionale o specializzato (perchè no dei fiori, data la collocazione), oppure attrezzature culturali (biblioteca e/o archivio storico), il cui decentramento non sarebbe favorito anche grazie all'efficace rete infrastrutturale delle piste ciclo-pedonali (figg. 2.40 - 2.42).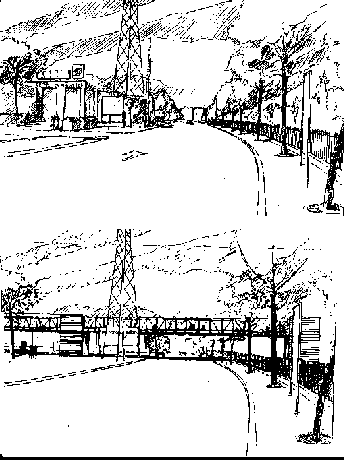 Superando poi Via La Spezia, (è necessario almeno un semaforo a raso), ci si immette in un quartiere di recente espansione residenziale, in cui la realizzazione delle piste è occasione di ricucitura delle aree verdi, per lo più di contenute dimensioni, racchiuse dal tessuto edificato senza un disegno che li organizzi e le colleghi opportunamente. Correndo tangenti al bordo del complesso scolastico di via Fratelli Bandiera e sfruttandone una porzione di giardino, si potrebbe ripensare la sezione stradale per ottimizzare gli spazi e proteggere il percorso ciclo-pedonale dal traffico automobilistico (2.41-2.43).
Superando poi Via La Spezia, (è necessario almeno un semaforo a raso), ci si immette in un quartiere di recente espansione residenziale, in cui la realizzazione delle piste è occasione di ricucitura delle aree verdi, per lo più di contenute dimensioni, racchiuse dal tessuto edificato senza un disegno che li organizzi e le colleghi opportunamente. Correndo tangenti al bordo del complesso scolastico di via Fratelli Bandiera e sfruttandone una porzione di giardino, si potrebbe ripensare la sezione stradale per ottimizzare gli spazi e proteggere il percorso ciclo-pedonale dal traffico automobilistico (2.41-2.43).
Se vogliamo poi concederci, sempre in un modo contenuto, un maggior margine di utopia, si potrebbe immaginare un sovrappasso ciclo pedonale ad una strada di traffico come via S. Pellico. Qui, grazie ad una rampa a dolce pendenza si può salire fino alla passerella sopraelevata - momento di qualificazione e di arricchimento del continuum di spazi verdi che stiamo immaginando di percorrere - che migliorerebbe assai anche i collegamenti con il centro commerciale, a sua volta funzionale all'intenso utilizzo delle piste ciclo-pedonali che si vuole promuovere: (come appunto testimoniano gli esempi tedeschi, realizzati cercando di combinare efficacemente nuova viabilità e percorsi per lo shopping) (2.44-2.46). Da qui, attraversando lacerti sopravvissuti di campagna, si giunge alla pista lungo la massicciata ferroviaria, chiudendo l'anello con un tracciato pianeggiante in cui le due corsie possono proseguire affiancate sotto una pensilina a struttura metallica, ammorbidita e protetta da rampicanti e arbusti frondosi (figg. 2.51 - 2.53).
LEGENDA
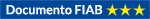
Linee guida FIAB, pubblicazione FIAB (schede, quaderni), pubblicazione di altri Enti redatta da FIAB.
Documento redatto da un tecnico e/o esperto della FIAB, non ufficiale FIAB.

Documento redatto da associazioni aderenti a FIAB o suoi membri.

Documento di persone o ente esterno alla FIAB, segnalazione documentazione presente in rete.

Documento esterno alla FIAB, segnalazione documentazione presente in rete. In Inglese.
Mentre il primo genere esprime posizioni ufficiali della FIAB (o comunque si tratta di uno "studio" promosso dalla FIAB), tutti gli altri possono essere validi contributi ma che a volte rispecchiano anche elementi non condivisi e/o oggetto di dibattito e di valutazioni diverse (non sempre strettamente tecniche).